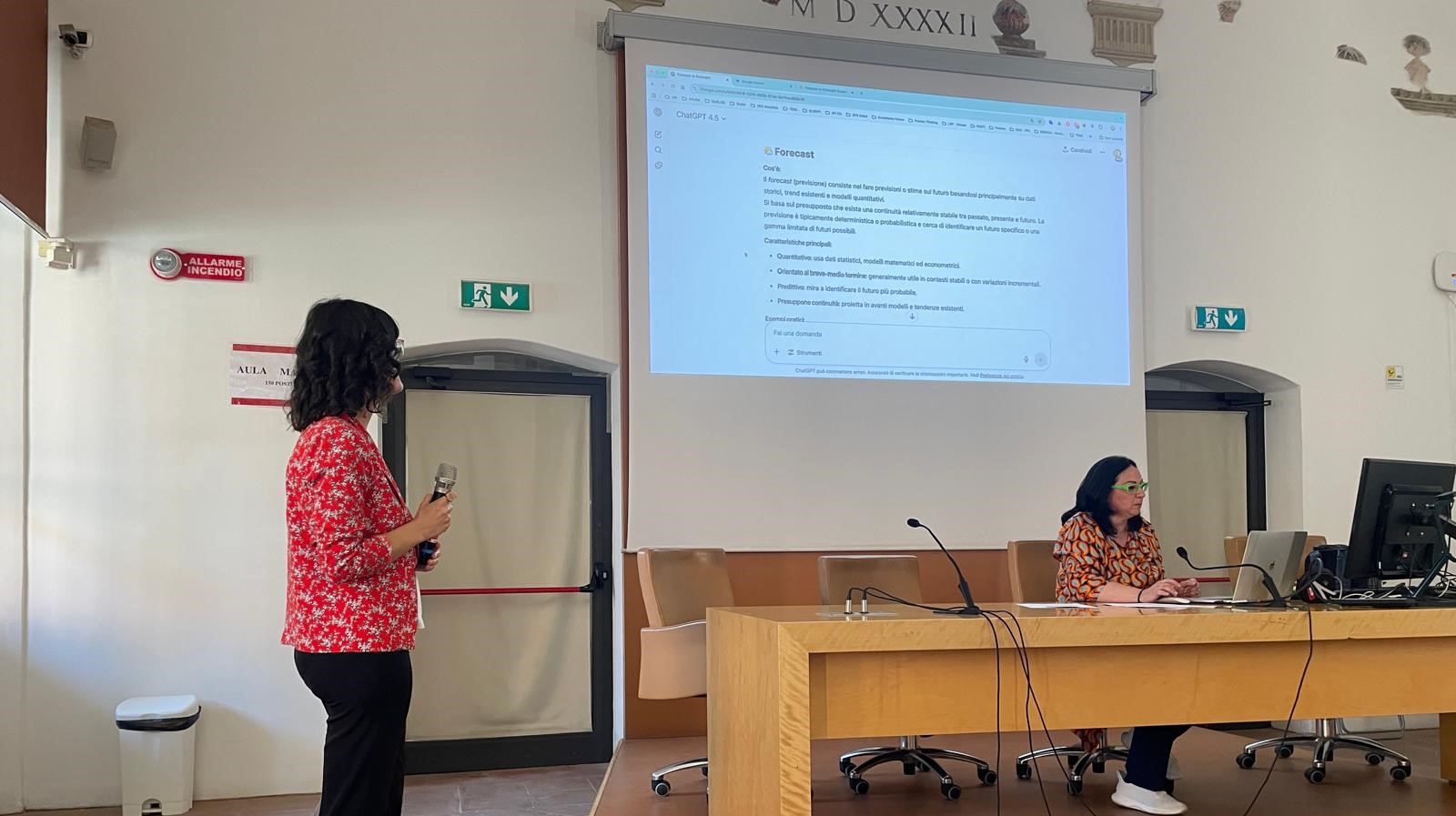Convegno Afi: Ai, regole e capacità di immaginazione per il futuro che ci aspetta
Dall’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale ai modelli di regolamentazione, passando per le implicazioni sui più giovani: riflessioni e scenari dal convegno annuale dell’Associazione futuristi italiani.
“Sei in grado di dirci la differenza tra forecast e foresight?”. È questa la domanda che Nicoletta Boldrini, membro del Consiglio direttivo dell’Associazione futuristi italiani (Afi), e Rossella Fava, executive coach Pcc Icf e foresigh facilitator, hanno posto in apertura del convegno annuale dell’Afi che si è svolto venerdì 27 giugno a Bologna. A rispondere non è stato il pubblico presente, ma tre sistemi di intelligenza artificiale: ChatGPT, Gemini e Claude.
Il forecast permette di elaborare delle previsioni basandosi su dati storici, mentre il foresight consiste nell’anticipazione dei futuri possibili. Le risposte delle tre AI sono state leggermente diverse, ma con alcuni aspetti ricorrenti: proposte di integrazione (“se vuoi posso produrre un report di questa conversazione” oppure “vuoi approfondire qualche aspetto in particolare?”), tono compiacente (“è un’ottima osservazione”) e linguaggio umanizzato (“cosa ne pensi?”). Tutte strategie pensate per mantenere l’utente coinvolto e attivo sulla piattaforma. “I modelli più recenti sono allenati sempre di più sul modello delle 3H affinché siano utili (helpful), onesti (honest) e che non siano nocivi (harmless)” ha aggiunto Fava. Anche se, hanno spiegato le due relatrici, in alcuni casi è possibile aggirare questi principi e approfondire temi di cui non sarebbe consentito parlare.
Dallo scambio di opinioni con il pubblico è emersa la necessità di prestare attenzione ai segnali sociali perché alcune persone, in particolare i più giovani, stiano utilizzando già l’AI quotidianamente. “E se una buona parte della società”, ha chiesto Boldrini, in futuro decidesse di delegare la propria responsabilità di agire e pensare all’AI? Che tipo di società sarà? È uno scenario che dobbiamo considerare”.
Se le applicazioni dell’AI sono ormai una realtà concreta, è necessario domandarsi come regolamentarle. È stato questo il tema dell’intervento di Antonino Rotolo, vicedirettore Alma Mater Research institute for human-centered artificial intelligence dell’Università di Bologna. Esistono tre modelli di regolamentazione: tradizionale basato su monitoraggio (svolto dall’AI) ed eventuali sanzioni; compliance by design che prevede l’integrazione di regole e conoscenze nei sistemi; valutazione e mitigazione del rischio (che comporterà la nascita di un mercato delle assicurazioni per l’AI).
L’Unione Europea ha scelto quest’ultimo approccio, fondando l’AI act su alcuni principi, tra cui la supervisione umana, la protezione dei dati, la trasparenza, la non discriminazione, la sostenibilità e l’accountability. Ma la difficoltà di trovare una posizione comune dei 27 Stati membri è evidente. “In Cina l’auto a guida autonoma è già realtà. In Europa non è possibile per problemi di omologazione. L’auto a guida autonoma deve poter violare le regole in alcune situazioni” ha spiegato Rotolo. “In un traffico a guida mista (autonoma e umana) dove tutti vanno a 70 km/h nonostante il divieto di 50 km/h, bisogna andare a 60 km/h per ridurre il rischio di incidenti. Se l’auto è automatizzata, deve decidere di violare il codice della strada”.
Giorgio Casoni, co-fondatore e Ad di Neocogita e docente presso il Dipartimento Advanced design unit dell’Università di Bologna, ha parlato dell’evoluzione di una società sempre più automatizzata:“Si stima che nel 2030 il 30% del valore mondiale della ricchezza verrà prodotta da agenti artificiali autonomi”.
Questi agenti sono sistemi capaci di operare in modo indipendente, con un intervento umano minimo, e di apprendere in modo continuo. Gli investimenti attuali, ha osservato Casoni, sembrano orientarsi più verso l’automatizzazione rispetto al potenziamento: “da un punto di vista del business è più conveniente perché comporta un maggiore efficientamento”.
Ma quindi le AI comprendono i concetti? E sono in grado di ragionare? Sono consapevoli? A queste domande ha provato a rispondere Pietro Speroni di Fenizio, matematico e curatore del blog AI Visions su FUTURAnetwork, spiegando come i sistemi di intelligenza artificiale siano in grado di “mappare” la realtà attraverso i vettori. “Se io prendo il vettore ‘re’ e sottraggo il vettore ‘uomo’, cosa ottengo? Regina. Anche noi abbiamo questi modelli concettuali. Le AI sono in grado di ragionare attraverso la matematica di questi vettori”, ha affermato di Fenizio. Per estrarre informazioni dalle AI possono essere applicati metodi diversi: utilizzare i prompt, chiedere all’AI di “immedesimarsi” in una persona (un esperimento contenuto nel volume “Mille schegge di futuro”) o far “dialogare” diversi sistemi di AI (come dimostrano le tavole rotonde del volume “Mille schegge di intelligenza artificiale”). La registrazione integrale del suo intervento è disponibile qui.
Sofia Scatena, docente di Psicologia della comunicazione e dei nuovi media digitali alla Cattolica di Milano, ha approfondito l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’essere umano, partendo da un recente, e molto discussa, raccolta di dati realizzata da un gruppo di ricerca del Massachusetts institute of technology (Mit) negli Stati Uniti. “Non è uno studio, è un pre-print, non è stato sottoposto a peer-review e il campione di partecipanti è esiguo”, ha detto, “sappiamo da anni che l’esposizione a media diversi genera attivazioni celebrali diverse”.
Il problema vero, e anche questo ormai lo sappiamo, è che i nuovi media digitali stanno abbassando la soglia di attenzione, soprattutto nei giovani. Questi sono i segnali di allarme”. Per questo motivo è necessario lavorare sulle competenze, sia dei giovani sia degli educatori e dei formatori. “Ci sarà una netta spaccatura tra professionisti che sanno usare le AI e chi non lo sa” ha sottolineato Scatena.
Il convegno si è concluso con una tavola rotonda a cui hanno partecipato Roberto Poli, presidente dell’Afi, Scatena e Fava su quello che ci aspetta nei prossimi anni. Per Poli è importante “riappropriarsi della capacità di immaginare il futuro. Siamo tutti diventati profeti di sventure, ma non sappiamo come immaginarci un futuro positivo”. Anche Scatena si è soffermata sulla perdita di capacità di vedere il futuro, soprattutto sui giovani: “Se perdiamo la capacità di sognare, di immaginare, allora siamo persi”, ha detto, specificando che è un fenomeno particolarmente evidente nei ragazzi tra i 17 e i 25 anni. “Dobbiamo chiederci la relazione che c’è tra capacità di immaginare il futuro e la mancanza di desiderio” ha concluso Fava, “perché siamo schiacciati dalla quotidianità e dal day by day”.