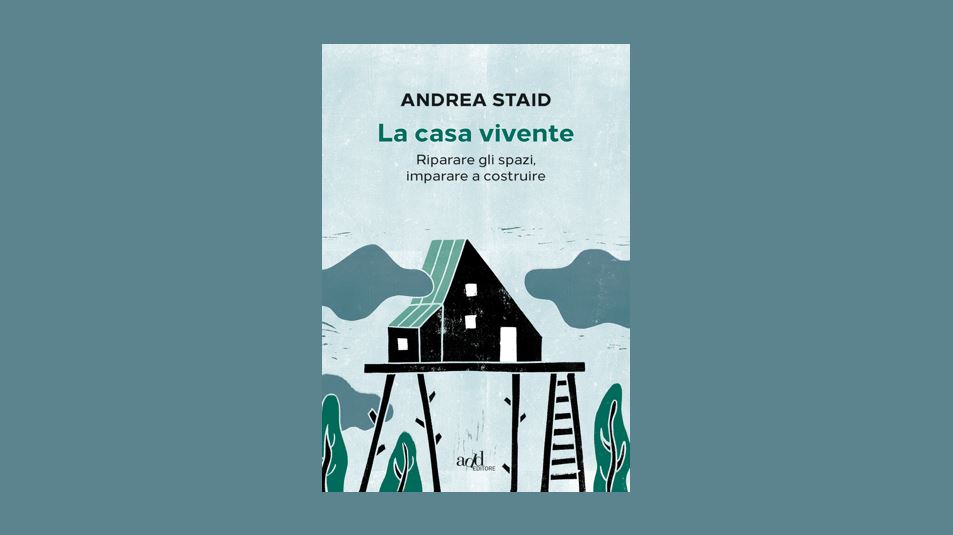Immaginare mondi, risignificare spazi
Nel suo libro l’antropologo Andrea Staid redige una mappatura dei diversi modi in cui è possibile abitare la Terra, raccontando come la casa del futuro passi dall’ibridazione e non dagli standard urbani occidentali.
di Beatrice La Tella
In molti idiomi vivere e abitare sono sinonimi, vicini a livello di campo semantico e di concetto. Questa simmetria non esiste nella lingua italiana, e la sua assenza è forse spia di un atteggiamento schizofrenico, comune al pensiero Occidentale, che ha avuto come conseguenze più disagi (quando non disastri) che benefici.
L’antropologo Andrea Staid pubblica il suo La casa vivente per Add Editore, proprio a partire dalla necessità di un decentramento, prospettico e fisico. Il volume si apre non a caso con una brevissima introduzione all’etnografia: non studio egemonico-quantitativo – lo sguardo di superiorità della civiltà (presunta) evoluta che osserva bonariamente società (presunte) arretrate – ma, al contrario, ricerca di stampo qualitativo fondata sullo scambio e il confronto alla pari. Conversando con le più diverse popolazioni nel corso dei suoi viaggi in Asia, Staid si è trovato spesso innanzi a visioni rovesciate delle nostre certezze (un esempio semplice quanto immediato: la paura di dormire con la porta chiusa piuttosto che con la porta aperta). Da questi raffronti è sorta la necessità impellente di rimettere in questione tanto il concetto quanto il potere stesso di abitare.
Occorre partire dall’idea che “la casa è un processo”: dimorare implica una presa in cura, un’azione sempre relazionale e continuativa. L’abitazione è un nodo e sprigiona contemporaneamente esigenze pratiche e funzioni simboliche che si muovono dallo spazio ristretto al paesaggio più ampio. Il modo in cui si occupa un luogo sottende una visione del mondo, una precisa struttura identitaria che non ha una norma fissa. Dimorare in un posto, infatti, non corrisponde necessariamente a stanziarvisi: “Abitare il mondo non vuol dire soltanto radicarsi, ma anche valicare confini”. L’abitare nomade, dunque, non è meno abitare di quello sedentario, anzi, mostra una diversa relazione tra l’uomo e il suo ambiente, dalla quale, sostiene Staid, si può trarre più di una lezione.
Può sembrare strano che si guardi a tende di pelle continuamente assemblate e smontate in mezzo al deserto in termini di futuribilità, eppure, proprio in queste usanze che a chi vive nei nostri condomini sembrano preistoriche, si possono rintracciare i semi di un modo più armonico di popolare il pianeta.
Per l’autore è fondamentale chiamarsi fuori dalla prospettiva industriale occidentale in favore di un approccio ecologista decoloniale. L’atto stesso della costruzione non deve più essere delegato: riappropriarsi dell’abitare significa, innanzitutto, conoscere i luoghi quanto i materiali che consentono l’edificazione e aprirsi inoltre alla possibilità di scoprirne di nuovi e insospettabili. Costruire, d’altronde, è un “atto immaginativo”, non un accumulo di materia inerte ma un’azione artigiana itinerante, ogni volta diversa, adattiva, che non può avere modelli prestampati cui obbedire ciecamente. La materia stessa è stata erroneamente avvertita nei secoli come passiva: oggi sappiamo invece che ha una propria agentività (agency), le cui ripercussioni si propagano anche nel sociale. Su questi argomenti, la studiosa di Scienza e Nanotecnologia dei materiali Laura Tripaldi scrive nel suo recente Menti parallele (effequ): “Forse in un futuro potremmo trovarci a vivere in case fluide, capaci di cambiare forma insieme a noi come il guscio di una chiocciola, o in città capaci di disassemblarsi e scomparire per ricostruirsi spontaneamente altrove. Finché queste prospettive fantascientifiche resteranno inaccessibili, possiamo accontentarci di sapere che le nanotecnologie odierne ci forniscono tutti gli strumenti per costruire e studiare sistemi capaci di organizzarsi, riprodursi e modificarsi in autonomia su diverse scale, mostrandoci che è possibile immaginare e progettare attivamente altre forme di vita e nuove menti”. La materia ha un’intelligenza ed è protagonista di importanti e costanti mutamenti: conoscerla è fondamentale per ripensare i nostri rapporti con essa e le infinite possibilità che ci dischiude.
Nel mondo del Capitalocene, termine che Staid ritiene più centrato di Antropocene per indicare gli influssi devastanti e trasformativi dell’uomo sul pianeta, l’unica possibilità che ci è data come specie è vivere – e dunque, abitare – alleggerendo l’impatto umano. Lasciandosi alle spalle l’etnocentrismo, l’antropologo preferisce guardare al dimorare indigeno come possibile maestro di un diverso stare al mondo, fatto di ibridazione e connessioni (non a caso nel testo l’autore cita direttamente Chthulucene di Donna Haraway, che fa del legame – letteralmente kin, “parentela” – il fulcro del suo pensiero). Osservando varie comunità, Staid ha scoperto case che sono spazi sociali potenzialmente illimitati, non individualizzanti, spesso con un proprio ciclo di vita – case che nascono, crescono e muoiono dissipandosi secondo le leggi naturali dello spazio in cui sorgono. Il libro propone dunque una serie di esempi di “architettura spontanea”: dalla goahti dei sami all’izba russa, dal tulou cinese alla tolek africana, Staid esplora case vive costruite in armonia con l’ambiente circostante, case mobili, orti galleggianti, dimore fatte di scale che finiscono sugli alberi, in una rassegna breve ma allo stesso tempo ricca e suggestiva.
“Oggi è chiara la necessità di uscire dalla bolla eurocentrica, di costruire in modo differente; abbiamo bisogno di progettisti, autocostruttori visionari, capaci di immaginare altri mondi per risignificare il modo in cui abitiamo i nostri spazi”.
Se la casa è un “dispositivo cognitivo”, che si muove non solo in senso spaziale ma anche culturale, Staid ritiene che questo dispositivo vada espanso, e per farlo è necessario muovere altrove il nostro sguardo. Ciò non significa però soffermarsi solo su realtà distanti: è sufficiente scoprire anche proposte poco note sorte in Italia, come A.R.I.A. Familiare, cantieri di autocostruzione sorti ad Amatrice dopo il sisma. L’Occidente come sistema di pensiero avversa da sempre queste pratiche di autogoverno, anteponendo l’efficienza (spesso presupposta) ai meccanismi di condivisione e la burocrazia all’immaginazione. Si tende a favorire l’intorpidimento dell’homo comfort a scapito della manualità dell’homo faber. “È importante ricordare che la casa è un bene d’uso, non un bene di consumo”, sottolinea Staid e in questo senso fornisce esempi di progetti, come Pianeta U.M.A.N.A. & C., che sono scuole-cantiere volte proprio a istruire alle pratiche di autocostruzione familiare. In un’epoca di kit di case da montare proposti da Ikea, in cui la standardizzazione crea lotti malsani identici a se stessi, questo tipo di realtà mostra che altre direzioni sono possibili. Se la rivoluzione urbana, con i suoi condomini iperindividualizzanti, con la sua riduzione di spazi comunitari e la sua omogeneizzazione del paesaggio, genera un disagio abitativo dai volti molteplici, è evidente che urge una controrivoluzione.
In questo senso Staid sottoscrive lo stretto legame che intercorre – o dovrebbe intercorrere – tra ecologia e lotta sociale: non riconoscere che le logiche capitaliste siano la causa principale della crisi ambientale significa mantenere uno sguardo parziale e insufficiente. “L’abitare deve diventare un progetto politico anticapitalista”, afferma in maniera diretta, proponendo poi un abecedario di buone pratiche basilari che passano dalla mobilità sostenibile alla riduzione dei rifiuti. È fondamentale ridimensionare l’umano e lasciare maggiore respiro al paesaggio, riportandoci al di fuori di quel centro in cui ci siamo storicamente auto collocati. Per comprendere questo scarto è sufficiente considerare che l’uomo rappresenta lo 0,01% della biomassa, contro le piante che corrispondono invece all’80%. È proprio alle altre specie che bisogna guardare per salvaguardare anche la nostra: un esempio è la fabbrica dell’aria realizzata dal botanico Stefano Mancuso, un sistema di filtraggio degli ambienti chiusi che si basa proprio sulla fotosintesi delle piante e la loro capacità di assorbire e degradare gli agenti inquinanti. Bisogna “pensare la fine dell’antropocene senza la fine della vita di noi animali umani sul pianeta”. Il primo passo è allo stesso tempo semplice e arduo: ammettere che il modo in cui abbiamo sempre abitato – infestato – il nostro pianeta possa non essere il migliore e cercare altrove nuovi paradigmi.
L’etnografia è un’esperienza di spaesamento, un approccio per cui ogni viaggio è scambio costante, attività transculturale contro ogni gerarchia e struttura verticale. L’obiettivo è progettare un abitare intraspecie, simile alle parentele auspicate da Haraway, che elimini ogni idea di ‘permesso calato dall’alto’ e riconosca pari dignità a tutto il vivente, concependo ogni specie come entità politica. Una volta superato il mito tossico della crescita e dello sviluppo infiniti sarà forse possibile smettere di infestare la Terra e cominciare ad abitarla e viverla, senza più separare i due concetti.
Risignificare l’abitare è risignificare l’umano: Staid invita a superare la paura che il mettersi in discussione reca sempre con sé e iniziare a concepirci diversamente come specie, agendo di conseguenza. Il suo invito, come la sua scrittura, è chiaro e privo di fronzoli: dobbiamo “immettere futuro nelle cose che si fanno nel presente”, azzardare nuovi immaginari perché la casa smetta di essere soltanto un edificio e ritrovi una più vasta rete di possibilità e significati.
di Beatrice La Tella